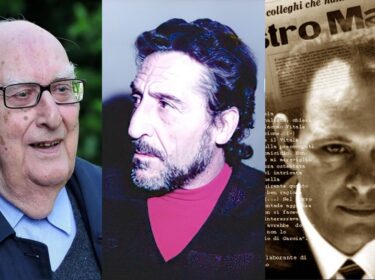In occasione del ventennale dell’iscrizione del sito «Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica» nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 9.30, la Sala Borsellino di Palazzo Vermexio ospiterà una giornata di studi dal titolo “Siracusa al tempo della Camera Reginale tra Bianca di Navarra e Germana de Foix: architettura, arti figurative ed economia”.
L’iniziativa rientra nel programma ufficiale delle celebrazioni per i vent’anni del riconoscimento Unesco e rappresenta uno dei momenti di maggiore approfondimento storico e culturale dedicati alla città e al suo ricco passato.
I lavori saranno introdotti e coordinati da Lorenzo Guzzardi, direttore scientifico del Ventennale Unesco, che accompagnerà il pubblico attraverso i diversi interventi previsti nel corso della mattinata.
Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali di Antonino Lutri, soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, e di Rita Insolia, direttrice della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo. Entrambi sottolineeranno il valore della ricerca e della divulgazione come strumenti essenziali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale siracusano, in particolare quello risalente al periodo medievale e rinascimentale.
Durante la giornata interverranno quattro esperti di rilievo nazionale, ciascuno dei quali offrirà una prospettiva diversa sul tema della “Camera Reginale”, istituzione che tra il XIV e il XVI secolo rappresentò un elemento di grande importanza politica, economica e culturale per la città e per l’intera Sicilia.
Il programma degli interventi
Ad aprire il ciclo di relazioni sarà Lucia Trigilia, direttore scientifico del Centro Internazionale di Studi sul Barocco, con una relazione dal titolo “Isabella di Castiglia e il rinnovamento edilizio a Siracusa nell’età del Rinascimento”. La studiosa analizzerà il ruolo di Isabella di Castiglia come figura centrale di una stagione di prosperità e trasformazione urbana. Durante la sua “Camera”, tra il 1470 e il 1504, la regina promosse un rinnovamento estetico e architettonico che segnò profondamente il volto della città. In quegli anni Siracusa divenne un centro di influenza catalana, dove fiorì il cosiddetto “Gotico mediterraneo”, con eleganti bifore, portali scolpiti e loggiati luminosi. Un periodo in cui la committenza colta e agiata favorì la presenza di grandi maestri come i Gagini, Laurana e Antonello da Messina, contribuendo all’affermazione del Rinascimento in Sicilia.
Seguirà l’intervento di Giuseppe Agnello, presidente onorario della Fondazione Agnello, che tratterà il tema «La Camera delle regine aragonesi in Sicilia».
L’approfondimento offrirà una panoramica sull’evoluzione istituzionale e territoriale della Camera Reginale dal 1282 al 1536, analizzandone gli aspetti giuridici, amministrativi, economici e sociali, con particolare attenzione al ruolo delle regine aragonesi nella gestione dei territori e nella promozione dello sviluppo locale.
Il terzo intervento sarà curato da Francesco Mannuccia, architetto restauratore, con la relazione «Archivi di pietra – Lo studio dei materiali e la scienza della conservazione».
Attraverso esempi concreti e l’uso di immagini, Mannuccia illustrerà come l’analisi dei materiali costitutivi dei monumenti, in particolare della Cattedrale di Siracusa, possa fornire preziose informazioni storiche e tecniche. Lo studio della pietra, delle malte e delle tecniche costruttive diventa così un vero e proprio “archivio” che racconta secoli di trasformazioni e restauri.
A chiudere i lavori sarà Arturo Alberti, architetto, con l’intervento «Giovanni Cabastida e Dalmazio di Sandionisio, due Catalani a Siracusa, tra tardogotico ed esordi rinascimentali. La Cattedrale di Siracusa tra il XV e il XVI secolo».
Al centro della sua relazione, le figure di due protagonisti di quella stagione artistica: Giovanni Cabastida, presidente della Camera Reginale fino alla sua morte nel 1471, commemorato con un monumento funebre nella Cattedrale, e Dalmazio di Sandionisio, vescovo della città e promotore di importanti opere di rinnovamento come la costruzione del nuovo organo, il coro ligneo a tarsie e la chiesa dei Miracoli.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale siracusano, che nel corso del ventennale Unesco sta mettendo in luce i diversi momenti storici che hanno definito l’identità della città. Un’occasione, dunque, non soltanto per studiosi e addetti ai lavori, ma anche per tutti i cittadini interessati a riscoprire un capitolo fondamentale della storia di Siracusa, quando la città, crocevia di culture e di potere, seppe fondere influenze iberiche e mediterranee, lasciando un segno indelebile nel paesaggio urbano e nella memoria collettiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA